Come avere un paio d’ali
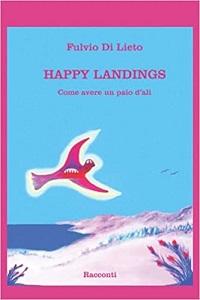
Dopo secoli di tentativi falliti (Icaro) e frustrazioni eccellenti (Leonardo), l’uomo è riuscito finalmente a volare. Grazie all’aereo, l’umanità sembra essersi riappropriata della dimensione felice ed eterea di cui godeva prima che Adamo ed Eva venissero cacciati dal Paradiso Terrestre. Oggi quadrigetti, trireattori e bimotori hanno sostituito in maniera piú o meno egregia quel paio d’ali che la bontà divina aveva accordato ai nostri progenitori. Nello spazio di poche ore possiamo spostarci da un continente all’altro, da una civiltà e una cultura che ci sono familiari ad altre spesso aliene e opposte. Ma non sempre una tale presa di contatto avviene in maniera fluida e senza intoppi. Spesso l’atterraggio in una realtà diversa produce traumi e delusioni. Ma può anche riservare gioie inattese e scoperte strabilianti. Questo libro narra appunto di decolli, permanenze in aria e atterraggi. Parla di uomini, donne e situazioni proprie della nuova realtà dell’andar per cielo, che sarà con molta probabilità la dimensione nella quale si svolgerà la nostra vita futura. E poiché un volo per dirsi ben riuscito deve concludersi con un atterraggio perfetto, ci auguriamo che i futuri voli dell’umanità finiscano con un buon atterraggio, che nel frasario iniziatico dei viaggiatori celesti si traduce: “Happy Landings”.
Clienti difficili
Peccati di gola
A qualcuno piace caldo
Bilance e bauli
Canale rosso
Falchi e colombe
Non è mai troppo tardi
Mal di terra
Nidi stranieri
Uccelli del paradiso
Senza nido
I Bonavoglia
Sorridere sempre
Prima classe
Conti e sconti
Uccelli rari
Buon atterraggio
I BONAVOGLIA
La nostra epoca non sembra voglia aprire gli occhi su una cruda verità: i vantaggi dell’automatismo, dell’elettronico, del supersonico, in breve, della macchina, sono illusori, alla stregua di un miraggio. Sperimentata una difficoltà, la speculazione inventiva dell’uomo escogita il marchingegno capace di eliminarla o di ridurla. Di primo acchito il prodotto ottenuto sembra perfetto: il toccasana che ci voleva. Poi, man mano che la macchina funziona, ci si accorge che legati ad essa, direttamente o per vie secondarie, ci siamo un po’ tutti noi e buona parte della nostra libertà.
L’uomo crea il Moloch che lo assoggetta.
Ma questa è pura accademia. Nella pratica, non si ha neppure il tempo per fermarsi a riflettere e creare delle alternative. Si vive e basta. Soltanto nei casi in cui la realtà devia dal binario del tutto programmato e organizzato, mettendoci sotto il naso gli imprevisti, solo allora viene fuori l’uomo e le sue prerogative psicofisiche, le uniche capaci di assecondare i capricci della vita.
I capricci della vita di quella aeronautica si materializzano con scioperi, ritardi per nebbia, dirottamenti, guasti meccanici.
Non è raro assistere a quadretti di vita aeroportuale come questo. Le maestranze di handling hanno indetto uno sciopero selvaggio, a tempo indeterminato. Non prestano servizio. Neppure gli addetti alle pulizie dell’aerostazione. Soli, disperati, gli impiegati di scalo della linea aerea X non sanno che pesci pigliare.
L’aereo è fermo sulla pista da un’ora, ma il capitano, per mezzo della radio di bordo, ha fatto sapere a terra che lui, senza scalette, non può scaricare i passeggeri nè, tantomeno, imbarcarne altri. Ha fissato un ultimatum categorico.
Se entro un’altra ora non si saranno provvisti della scala, l’aereo ripartirà per la prossima tappa, e tanto peggio per i passeggeri che dovevano sbarcare.
Capannelli concitati, impiegati sparpagliati in tutte le direzioni, per vedere se presso qualche altra compagnia aerea sia reperibile una scaletta; telefonate da “si salvi chi può”, anche perché il gruppo dei passeggeri in partenza si amalgama nel formulare proteste e minacce.
Quando, ormai, tutto sembra irrimediabilmente perduto, in virtú di quell’apporto della fantasia umana di cui si parlava prima, si trova la soluzione. Uno degli impiegati, mentre imbocca il corridoio che porta dalla hall della dogana ai W.C., nota una di quelle scale in dotazione dell’Azienda Elettrica Comunale per le riparazioni alle linee dell’alta tensione. Sono scale retrattili, che possono innalzarsi fino a piú di 20 metri dal suolo. Nel cervello dell’uomo scocca la scintilla dell’inventore. Ecco la scala che può, che deve servire alla bisogna.
Torna dal caposcalo, comunicandogli la scoperta. Dopo la necessaria autorizzazione dei proprietari della scala, che per fortuna non sono in sciopero, gli impiegati trascinano il pesante attrezzo verso la rampa dove sosta l’aereo. Sembra di assistere a un scena di assedio; i guerrieri che muovono con arieti e macchine d’assalto contro la fortezza.
Dietro, a distanza serrata, gli impiegati precedono le coorti dei passeggeri in partenza, piú gruppetti di addetti allo scalo, curiosi di assistere all’epilogo di un cosí estemporaneo imbarco. Chiude la fila una scorta di polizia e l’autoambulanza, inviate, per sicurezza, dalla direzione aeroportuale. La prudenza non è mal troppa!
Ma le difficoltà non sono finite. Il capitano si rifiuta di usare quella scala per farvi scendere dei passeggeri.
«La responsabilità è mia!» strilla dalla carlinga al caposcalo sotto l’aereo.
«Ma che responsabilità d’Egitto! – strilla di rimando quest’ultimo, inviperito qui si perdono dei milioni se non imbarchiamo. Presto, non stia a sottilizzare!».
«Non mi fido di quell’aggeggio – insiste il pilota. Non reggerà alla discesa di un solo passeggero».
Senza replicare, il caposcalo ordina di accostare. La manovra viene eseguita in scioltezza. Quando la sommità ha toccato l’apparecchio in corrispondenza di uno dei portelloni di uscita, consegnato ad uno degli impiegati la cartella e la radio portatile, il caposcalo si concentra come un trapezista prima di effettuare un triplo salto mortale senza rete poi, guardando con sfida in direzione della carlinga, comincia a salire.
Sulla pista si è fatto un silenzio totale. Qualcuno scatta delle foto; i passeggeri cominciano a rivedere l’immagine negativa che si erano creata sulla compagnia aerea e i suoi impiegati.
«E in gamba, l’uomo!», afferma un americano, addentando il suo enorme sigaro.
Piolo dopo piolo, con piglio vigoroso, il caposcalo si arrampica. Arrivato su in cima, si volta a rimirare la folla. Sono tutti per lui. Lo raggiunge un’ovazione entusiastica.
«Bravo, bravo!» gridano le scolare di un collegio battendo le mani.
Ad una simile prova di coraggio, confortata dalla partecipazione popolare, la pignoleria del capitano si smonta.
Il portello si apre e, lentamente, comincia lo sbarco dei passeggeri e l’imbarco di quelli in partenza.
Questo episodio serve a convalidare la tesi, secondo la quale nulla può fermare la fantasia umana, specialmente se insorgono necessità impreviste.
Non cosí per le macchine. Benché frutto di perfezionatissimi studi di laboratorio, costruite con metalli speciali, dotate di sistemi capaci di segnalare il minimo inconveniente con ore di anticipo, le macchine sono la famosa pentola del diavolo, perfetta in tutto, ma senza l’indispensabile coperchio.
Il coperchio, delle macchine, è rappresentato dalla loro mancanza di fantasia. Quando decidono di non andare, non vanno. Inutili risultano preghiere e minacce, o l’esposizione d’argomenti clic convincerebbero con la logica il piú duro dei cervelli umani.
La macchina non ha arbitrio; è come un pretoriano. Si lascia distruggere, ma non viene meno alla consegna ricevuta.
Queste osservazioni, o qualche speculazione cerebrale non molto dissimile, attraversavano la mente del capo-meccanico alle prese con una turbina del postale che faceva servizio tra due aeroporti dislocati nel quadrilatero geografico Rio de Janeiro, Asuncion, Santiago e Buenos Aires. Specificare i nomi non ha importanza; quegli aeroporti sono talmente simili l’uno all’altro che, descrivendone Lino, si dà la cartina topografica esatta di tutti gli altri.
L’aereo era incappato in una tempesta di vento, mentre sorvolava il Paranà; un vero tifone. Nulla da fare per la struttura dei turboreattori, uno dei quali si era bloccato costringendo il pilota a un atterraggio forzato, una vera acrobazia da “pattuglie della morte”, sulla prima pista che si era presentata sotto le ruote dell’aereo. Si trattava di uno dei tanti fazzoletti d’asfalto rubati alla giungla: una specie di casamatta, con veranda in funzione di terminale passeggeri, l’ufficio di polizia, il telefono e il W.C. Al telefono si attaccò subito il capitano, chiamando la direzione della Compagnia nel capoluogo. Dopo vari tentativi, riuscí ad ottenere che venisse inviato un ingegnere a bordo di un mezzo di emergenza. Nel frattempo, gli promisero, avrebbero richiesto alla polizia del distretto dove era situato l’aeroporto, di mettersi a disposizione dei passeggeri per qualunque necessità.
Dal canto loro i passeggeri, scampati come erano al disastro totale, non chiedevano altro che di benedire la sorte, in pace, possibilmente al riparo dal sole, senza fare programmi immediati. Li sistemarono alla meglio all’interno della casamatta dove, a detta di un incaricato della direzione aeroportuale, era anche possibile bere un caffè caldo e qualche bibita ghiacciata d’importazione.
Il capo-meccanico dell’aeroporto, un omone che maneggiava chiavi inglesi e pinze con la cupa rudezza di un maniscalco, sbuffava attorno al turbo-reattore, mentre cercava di abbrancarlo, proprio come farebbe un maniscalco alle prese con un mulo riottoso.
Riuscí a smontare la camicia del motore, e fu già un successo. Fatto ciò, l’uomo mollò gli arnesi, rifugiandosi all’interno della stazione, dove affogò la propria frustrazione in un enorme boccale di birra locale.
«Maledizione ai motori a reazione – confidò al gestore della caffetteria. – Dimmi un po’ tu se devono farli cosí complicati da maneggiare!»
Il cafetero annuiva meditabondo, mentre cercava di star dietro alle richieste che piovevano dal gruppo dei passeggeri.
«Calma, signori, uno alla volta. Qui non siamo in albergo, né tanto meno a palazzo reale! Uno alla volta!».
Il capitano, da parte sua, si era sistemato col secondo e la hostess fuori della casamatta, con sedie ed un tavolino all’ombra di una palma. Da quel posto era possibile scrutare il cielo per diversi chilometri verso l’interno della sierra: da quel corridoio sarebbe dovuto scendere l’aereo di soccorso, con l’ingegnere e i pezzi di ricambio.
«Staremo a vedere» disse il secondo pilota «se manderanno veramente questo ingegnere».
E il capitano:
«Perché non dovrebbero? In ogni caso, io non mi preoccupo. Qui si sta bene e non si volteggia in aria come qualche ora fa. Vero Estrelita?».
«Dio mio – esclamò la hostess – non mi ci faccia pensare. Credevo di non uscirne viva».
Il secondo pilota sembrava preoccupato.
«Anche a me sta bene il riposo, non dico questo. Ma, – e indicò il meccanico, di nuovo alle prese col motore – non vorrei che il nostro amico commettesse qualche grosso guaio irreparabile. Da come suda, si direbbe che voglia mangiarselo!».
«No – fece il capitano – quello lí, al massimo può svitare la camicia. Per il resto, non credo che possa fare molto».
L’aereo di soccorso arrivò nel tardo pomeriggio. Ne discesero uno steward, un funzionario della compagnia e, finalmente, l’ingegnere. Era minuto, magro come un grissino. Di robusto e rassicurante aveva solo un paio di baffi nerissimi e un cronometro al polso. Lo consultava con un gesto meccanico ogni due-tre minuti.
Al capitano che gli spiegava quello che era successo, confidò.
«Non ci faccia caso se guardo l’orologio cosí spesso: è che dopo quest’aereo ne ho un altro a Puerto Ventura».
Il capitano, sbalordito, chiese:
«Sempre le tempeste?».
L’ingegnere scosse il capo.
«No – ribatté desolato. – Le ruote all’atterraggio. Un vero disastro. Ci vorrà l’aiuto di Nostra Signora del Pilar prima che io, Alfonso Hermano Miguel Herrera, possa ridistendermi sul letto di casa mia».
«La capisco – annuí fraternamente il capitano — ma adesso ci tiri fuori da questo deserto. La gente non ne può piú. Qui – si fece sospettoso mentre parlava – se non si riparte entro stasera, scaricheranno su di noi la paura e la rabbia. Ricorda il caso di Punta Vallarta, nel giugno scorso?».
L’ingegnere trasalí al ricordo di quanto era capitato all’equipaggio del DC6 ammarato in una palude nel distretto poco distante. Costretti a rientrare a piedi, denudati dai passeggeri inferociti, e morsi dalle micidiali zanzare di quella regione. Una vera barbarie!
«Farò del mio meglio, capitano – promise Herrera. – Andiamo all’aereo!».
Era arrivato al momento opportuno, pensò, mentre urlava al meccanico:
«Fermo, per l’amor del cielo, non è un vagone ferroviario, è un reattore !».
Il meccanico, resosi conto che gli attrezzi di cui era in possesso si erano rivelati inutili, aveva pensato di abbandonare gli schemi raccomandati dalla prassi e seguire la sua ispirazione istintiva. Armatosi di una lunga spranga di ferro, tentava di forzare il rivestimento esterno del reattore per mettere a nudo le parti piú delicate, dove, probabilmente si era verificato l’intoppo.
«Madre de Dios! – ruggiva Herrera, – ma cosa voleva fare, smantellare l’intero aeroporto? Si tolga di mezzo».
L’uomo non si scusò neanche. Rientrò, sbuffando, al bar dove si attaccò al solito boccale di birra.
«Viva i motori a pistone — gridò al barista — quelli sí che si lasciano fare. Non sono cosí sofisticati. Puah!».
I passeggeri si riscossero dal letargo e uscirono sulla pista, per assistere all’azione del taumaturgo appena arrivato.
L’ingegnere, a onor del vero, a furia di andare su e giú per l’America Latina, riparando aerei con i mezzi a sua disposizione, era un mostro della meccanica d’emergenza. Si muoveva con la scioltezza rude di quei chirurghi che hanno fatto pratica sui campi di battaglia, dove piú che la tecnica serve la velocità d’esecuzione degli interventi e un certo acume sensorio che fa capire subito, senza studio né riflessione, quasi al fiuto, quale è il modo migliore per salvare il ferito. Le prime volte si può anche sbagliare. E umano. Ma poi, giorno dopo giorno, uno acquista quella pratica con l’aiuto della quale si scopre subito il male e il suo rimedio, seguendo i consigli che provengono da quel grande computer che è il cervello umano, programmato da migliaia di casi e da cento e piú sconfitte.
Questa digressione era per gli sconosciuti meriti del Dr. Alfonso Hermano Miguel Herrera e per quei tanti, come lui, che sulla pista di tutto il globo terracqueo, in silenziosa umiltà, permettono alla scintillante macchina del trasporto aereo di procedere a testa alta, come dicono la pubblicità nei giornali e gli slogan sui cartelloni lungo le autostrade degli aeroporti.
Quel contributo umano per l’appunto senza il quale motori e computer, una volta lasciati soli, sarebbero un cuore senza sangue.
Ma di queste conclusioni, il Dr. Herrera non si preoccupava. La gente di buona volontà, in genere, non mette mai sulla bilancia il peso del bene che fa.
Nel momento della nostra storia, la sua preoccupazione maggiore era la luce del sole. Se il sole calava, era finita per tutti. Non si poteva lavorare alla luce delle torce elettriche; se di torce elettriche se ne sarebbero trovate in quella specie di avamposto sahariano !»
Indossò la tuta, abbrancò la borsa dei ferri e, con la sveltezza di uno scoiattolo, si arrampicò sulla scaletta fin sotto il reattore. Vi rimase appollaiato, mentre lavorava; i pezzi che smontava li passava al meccanico che era ritornato alle sue reali dimensioni. Dopo una mezz’oretta di quel passamano, il nucleo del reattore era messo a nudo: un intrico di fili, ventole e valvole.
L’ingegnere Herrera vi armeggiò un po’, sfilò un cavetto di rame, lo rinfilò.
Si accorse di un certo gioco anomalo degli incastri e, alzatosi sulla piattaforma di lavoro, cominciò a ridere. Il capitano e gli altri, che erano di sotto, si guardarono allibiti; con ogni probabilità, pensarono tutti, lo stress, accoppiato alla complicatezza dei reattori Mac Danuelle Rotney, avevano avuto ragione dell’equilibrio mentale del poveretto.
«Si calmi, ingegnere – gridò dal basso il capitano – se la faccenda è cosí complicata, lasci perdere. Ci faremo mandare un motore di ricambio!».
«No, ma cosa ha capito – disse divertito l’ingegnere, stirandosi i baffi. – Al contrario, è piú semplice di quanto pensassi».
«Dio sia lodato», esclamò la hostess.
Intanto, l’ingegnere, sempre col volto atteggiato a una grande allegria, scendeva dalla scaletta.
«Allora…?» gli chiese un po’ seccato il capitano.
«Mi serve una donna…» fece di rimando l’ingegnere.
Tutti si guardarono sconcertati, mentre la hostess chinò la testa, arrossendo, se in quel clima è possibile far notare sul viso un qualsiasi cambiamento di colore.
«Ma ingegnere! – aggiunse con tono sdegnato il secondo pilota. – Le sembra questo il momento per simili faccende?»
«Un po’ di contegno non guasterebbe, – riprese un passeggero –dopo i guai che ci state procurando!».
«Calma, signori, calma! – strillò l’Herrera inviperito. – Qui ci stanno saltando i nervi. Voglio una donna, perché soltanto una donna può avere tanti capelli in testa da dover usare una forcina. E a me serve un semplice umile fermaglio da capelli, ecco!».
Stupore del capitano.
«Un fermaglio da capelli? Ma non vorrà dirmi che lei farà andare quell’aggeggio lí con un semplice pezzetto di ferro? Suvvia, ingegnere, qui stiamo sfiorando il ridicolo».
«Capitano! – esclamò Herrera. – Il competente di motori sono io, e se le dico che un semplice fermaglio da capelli basta a far rimettere in moto quella diavoleria in titanio supersoni-temperato, vuoi dire che non c’è altro sistema in mezzo a questa steppa». Poi, abbassando il tono della voce:
«A meno che lei o qualcuno dei signori presenti non abbia un’idea migliore. In questa materia nessuno è infallibile».
Ci fu un enorme silenzio, rotto solo dagli striduli richiami degli uccelli che sorvolavano il campo, per rifugiarsi nella foresta.
Alla fine, parlò il capitano.
«Va bene» disse paziente «ormai ne ho viste tali e tante in questi trent’anni di carriera, che credo in tutti i miracoli». Poi, rivolto alla hostess:
«Estrelita, lei ce l’ha un fermaglio?».
La ragazza, delusa:
«No, signor capitano, non ne porto».
«Allora domandi ai passeggeri, si arrangi come può, ma trovi questo benedetto fermaglio. In queste cose una donna può tutto».
Stranamente, delle tante donne imbellettate e ingioiellate di cui era composto il gruppo dei passeggeri, solo una suora carmelitana in trasferimento da una missione al capoluogo, fu in grado di fornire l’oggetto. Per toglierselo, si fece accompagnare dalla hostess al bagno e lí, soffrendo di vergogna, rimosse dalla testa la grande cuffia bianca e poi sciolse i capelli. Erano nerissimi e belli, e la hostess non poté trattenersi dal fare un complimento alla religiosa. Questa diventò di brace.
«Per l’amor del cielo, signorina, non mi faccia peccare. Dopo il miracolo di questa mattina, dovremmo solo pregare».
Il fermaglio venne consegnato all’ingegnere come una reliquia. Svelto come un grillo, Herrera si riarrampicò sotto il reattore, cavò dalla valigia dei ferri il saldatore autogeno e gli occhialoni. Per alcuni attimi si videro zampillare fiotti di scintille dal ventre del motore: sembravano i bengala che accendono i bambini nelle feste di Natale.
Dopo due ore dall’arrivo dell’ingegnere, il capitano entrò nella cabina e si calò nella poltroncina di guida. Sperando nella sua buona stella premette il pulsante di accensione. Prima in sordina, poi piú ampia e forte, gli rispose la musica dei reattori in funzione; li portò al massimo, a diverse riprese. Sembravano appena Usciti dalla fabbrica.
Il suo orecchio abituato, come quello di un grande maestro concertatore, notava il pulsare all’unisono delle turbine, la ripresa pronta al comando dell’acceleratore.
Quando mise fuori dal finestrino della cabina la mano sinistra col pollice rialzato, un urrà clamoroso si levò dalla pista.
L’ingegnere fu portato a spalle fino alla caffetteria, dove i passeggeri fecero a gara per offrirgli da bere.
Finalmente, come Dio volle in quella lunga giornata, col sole che scompariva dietro la striscia viola della giungla, l’aereo rullò sulla pista, si staccò dalla terra, impennandosi come un purosangue man mano che saliva i gradini della quota.
Lo seguí, dopo un quarto d’ora, l’aereo di emergenza con a bordo l’ingegnere.
Solo, al margini della pista, sagoma blu contro il crepuscolo, era rimasto il meccanico col suo boccale di birra in mano.
«Madre de Dios, — esclamò sorseggiando — che giornata!».

